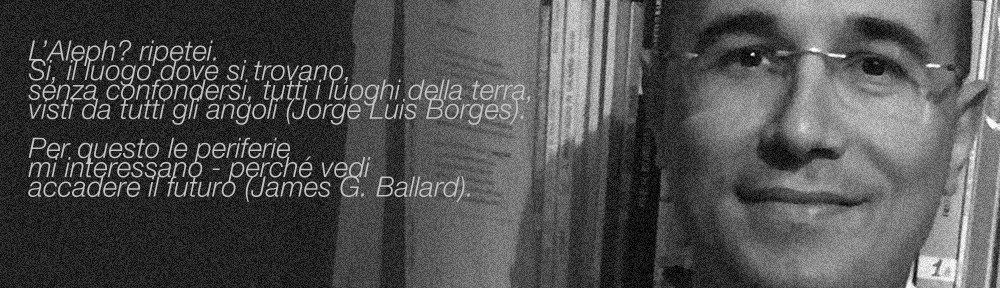Uno, nessuno o una pluralità di partiti? Cosa ha rappresentato il Partito Democratico nei suoi dieci anni di storia avviata dalle primarie del 14 ottobre 2007 e forse finita con le elezioni del 4 marzo 2018? Nato dalla fusione tra, soprattutto, Democratici di sinistra e Margherita, il PD è stato un partito riuscito o un partito mancato? Con quali criteri valutare la più recente e, forse, ultima testimonianza di una razza in via di estinzione, quella dei partiti? Su questi interrogativi è costruito il volume “L’ultimo partito” dei politologi milanesi Paolo Natale e Luciano Fasano (Giappicchelli, 2017, pp. 163, euro 17), che raccoglie e mette in ordine una grande quantità di dati riguardanti il consenso elettorale (tanto nazionale quanto locale), le primarie, gli organismi centrali (assemblea, direzione, segreteria) e i gruppi parlamentari che hanno segnato la storia decennale del PD, prima del tracollo nelle recenti politiche.
Gli autori dichiarano che si può “vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto” e concludono l’analisi con un punto di domanda “un partito mancato?”. Non si può non riconoscere come il PD abbia rappresentato la forza centrale dell’ultimo decennio della politica italiana: ha espresso i presidenti della repubblica, ben quattro presidenti del consiglio sui sei succedutisi, è stato al governo nazionale per quasi sette anni degli ultimi dieci, ha governato quasi tutte le regioni e un numero incredibilmente alto di città, ha varato riforme importanti e ne proposto altre assai ambiziose, ha continuato a rappresentare una comunità di forte mobilitazione con migliaia di iscritti e milioni di partecipanti alle primarie.
Nonostante tutto questo, Natale e Fasano spingono a “guardare prevalentemente ai limiti del PD, invece che ai risultati positivi che ha ottenuto, [in quanto ciò] può essere utile, quanto meno provocatoriamente, a interrogarsi in maniera più profonda sui problemi che questo partito ancora incontra” e che le ultime elezioni hanno impietosamente evidenziato. Il termine politologico chiave di questa interrogazione profonda ci pare essere “istituzionalizzazione”, quel tipico processo che porta un’organizzazione a consolidarsi, a diventare progressivamente un soggetto dotato di vita propria, un soggetto i cui scopi e valori di riferimento risultano riconoscibili tanto da rappresentare un’identità stabile e solide barriere all’uscita. Il livello di istituzionalizzazione del PD è stato scarso, si è trattato di “un partito vittima di una continua incompiutezza”. Avvicendamenti nella leadership (ben cinque segretari in dieci anni, sei con il reggente Martina), scissioni o almeno continue defezioni, cambiamenti repentini di linea politica, eccessiva litigiosità tra le varie correnti – hanno messo in evidenza come il PD non sia stato affatto un partito ma semmai una pluralità di partiti. E ciò non ha riguardato solo l’eredità delle tradizioni post-comunista e post-democristiana (anzi l’aumento del numero di nativi democratici negli organismi dirigenti è parso permettere il superamento di questa anomale origine) ma la presenza di anime diverse la cui conflittualità si è intensificata piuttosto che raffreddata con il passare degli anni. Nel PD hanno sempre convissuto, secondo la terminologia proposta da Henry Drucker, un’anima etico-egualitaria, un’anima socialdemocratico-laburista e un’anima democratico-riformista che solo a tratti hanno trovato equilibrio e coesione. Differenti poi, se non inconciliabili, sono stati gli orientamenti su questioni economico-sociali (pro-labour o pro-market) e questioni etico-valoriali (pro-life o pro-choice). Tradizioni, anime e orientamenti diversi che hanno disegnato almeno tre partiti diversi: il partito amalgama di Veltroni, leggero e parlamentarizzato, riformista e a vocazione maggioritaria; il partito old-style di Bersani, strutturato e centralizzato, socialdemocratico e a vocazione identitaria; il partito pragmatico di Renzi, incentrato sul leader e capace di utilizzare tutte le risorse disponibili (finanche l’alleanza con Verdini) per conseguire i risultati desiderati. E ad ogni cambio di segreteria sono cambiati i valori guida, l’impianto organizzativo e persino l’elettorato di riferimento.

Gli esiti dell’incompiuto processo di istituzionalizzazione sono stati perciò, da un lato, una scarsa capacità di prendere decisioni e, dall’altro, una sostanziale disorganicità tra i suoi diversi livelli organizzativi e territoriali. Da un lato, il partito si è riprodotto come partito delle primarie, che hanno mobilitato milioni di elettori e che sono riconosciute dagli stessi iscritti come costitutive e irrinunciabili, ma che hanno finito con l’essere percepite come un fine piuttosto che un mezzo: cosa che tra l’altro ha indotto calo di partcipanti e accentuazione degli sbilanciamenti territoriali (meridionalizzazione). Dall’altro lato, si è sempre riscontrata una mancata sintonia tra i vertici centrali (party in central office) e organizzazioni periferiche (party on the ground), che ha impedito alle scelte dei segretari succedutisi di improntare tutta l’organizzazione, come nel caso della rottamazione proposta da Renzi che non ha attecchito sui territori.

Natale e Fasano si sono fermati all’analisi di una storia, prima dell’esito elettorale del 4 marzo. Non si sono sbilanciati a indicare quelle che potevano essere linee di sviluppo, a dichiarare se il progetto aveva ancora possibilità di consolidarsi o invece poteva dirsi esaurito. Hanno però segnalato la criticità della fase attuale (“i prossimi mesi saranno probabilmente decisivi”) in cui una leadership, rafforzata dall’ultimo congresso ma isolata dagli elettori, e un’organizzazione indebolita da spinte centrifughe e quasi “senz’anima”, incapace cioè di selezionare classe dirigente riconosciuta ed elaborare cultura politica, hanno affrontato la sfida delle elezioni politiche in un contesto in cui l’aggregazione di centro-destra è stata di nuovo competitiva e i consensi del Movimento 5 Stelle sono cresciuti considerevolmente. Il risultato, in percentuale e in assoluto, è stato il più basso di sempre: il Pd ha racimolato meno del 19%, ossia poco più di sei milioni di elettori (la metà di quelli raccolti dieci anni fa da Veltroni). Insomma, le elezioni politiche del 4 marzo potrebbero aver intonato il de profundis dell’ultimo partito e con esso l’estinzione di una razza. E ciò avrebbe naturalmente delle conseguenze per la nostra democrazia rappresentativa.