
|
|
Il 19 aprile 2020 alcuni specialisti nei campi della sanità e dell’abitare* hanno inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica Italiana. La constatazione che motiva la lettera, sebbene nel testo rimanga sottintesa, è che nella Task force antivirus il Governo non ha nominato architetti, ossia specialisti dell’abitare. Ma “salute, economia e habitat” – fanno presente gli autori – sono “parti integranti della nostra vita quotidiana”. Ora, l’“emergenza prodotta dalla pandemia ha evidenziato – essi dicono – la nostra impreparazione ad affrontare eventi simili”, mettendo tra l’altro in luce che nell’attuale “modello di abitazione” non sono state tenute “in conto […] tali eventualità”. Ciò rende dunque necessario concepire un “modello alternativo” a quello fin qui adottato.
Partendo da questa considerazione, gli autori propongono una serie di accorgimenti pratici, suddivisi in quattro punti, per l’uso e la configurazione degli spazi domestici in funzione della difesa dai contagi. I suggerimenti avanzati sono ragionevoli e condivisibili e ci auguriamo che, per quanto possibile, vengano tradotti in azioni e opere.
Ma questa iniziativa pone dinnanzi un tema implicito ben più profondo, che riguarda il significato stesso dell’abitare e della configurazione architettonica dello spazio. Possiamo esplicitarlo nel modo che segue.
In tutte le culture arcaiche e tradizionali, l’abitazione è sacra, nel senso autentico del termine: esclude il proprio altro. In particolare, esclude quell’altro che è il profano, il caos dell’informe che va vinto perché vi sia un ordine abitabile. Così, porre le fondamenta è separare lo spazio in cui si è al sicuro dallo spazio inospitale e straniero che si deve lasciar fuori (e i greci pensano questo lasciar fuori nel modo più radicale come un lasciar nel nulla). Nella decisione di piantare le fondamenta è contenuta l’uccisione che divide lo spazio cosmico da ciò che, in quanto amorfo e caotico, non lo è. Lo spazio cosmico è questo taglio, prende significato in questa esclusione.
Che peraltro è la riproposizione dell’atto uccisorio originario, quello col quale il dio ha creato l’ordine del mondo liberandolo dalle tenebre mostruose dell’informe e del demoniaco. In India, la prima pietra della casa veniva posta sopra un palo piantato nel punto esatto del terreno al di sotto del quale, a parere dell’astrologo, si trovava il Serpente che sosteneva il mondo. Il palo era quindi in realtà conficcato nel corpo del Serpente, che veniva ucciso nello stesso modo in cui in origine era stato ucciso dal dio Soma. Secondo il Rg-Veda, infatti, Soma ha creato il mondo tagliando la testa del Serpente, simbolo del caos che il dio deve escludere per fondare il cosmo.
La costruzione primordiale di una casa è dunque un evento cosmogonico. Essa riproduce la prima fondazione, riattualizza il modo in cui all’origine è avvenuta, agendo secondo il modello divino ideale. La sacralità dell’abitazione è cioè copia della sacralità divina che essa ripropone. Come quest’ultima, l’abitazione è tanto più buona e bella quanto più sta in se stessa, saldamente determinata e separata dal proprio altro.
Anche quando il divino tramonta e l’homo religiosus lascia il posto all’uomo moderno e contemporaneo che vive immerso nel secolo, il saeculum continua ad essere pensato secondo il senso che alle cose il sacro ha conferito: ognuna di esse è se stessa nella misura in cui è separata dalle altre, come ognuno dei sassi che compongono un mucchio è se stesso nella misura in cui da ultimo è indifferente e indipendente agli altri. Nel tempo della secolarizzazione del mondo, l’uomo abita ancora in modo sacro: isolato dagli altri, soggiorna negli isolati in cui si sviluppano le sue città (Koolhaas parla di New York precisamente come di un “arcipelago prosciugato di isolati”, ognuno dei quali è “separato come un’isola, fondamentalmente solo con se stesso”).
È appunto perché lo spazio desacralizzato del contemporaneo è ancora uno spazio pensato secondo l’ordine del sacro, cioè secondo l’ordine dell’esclusione del proprio altro, che la casa è solo quel che essa è e non può essere altro. Essa esclude ogni altro significato diverso dal proprio, da quello cioè voluto da un certo progetto architettonico o da una certa idea urbanistica.
Così accade quel che in questo frangente rilevano gli autori della lettera. Un “modello di abitazione”, quello pensato non tenendo conto dell’evento pandemico – peraltro più o meno imprevedibile, almeno nella specifica configurazione con cui si è manifestato di fatto –, si mostra inadeguato, ma l’abitazione continua a restare fissa nel significato che essa ha a prescindere dall’evento in questione. L’evento determina un mutamento nel significato dell’abitazione, ma la forma dell’abitazione resiste indifferente. Non si apre ad un altro significare, non acquista un nuovo volto. Rimane per sé. E vi rimane anche se, come fanno gli autori, si propone un “modello alternativo” di abitazione. In esso infatti si ripresenta la medesima esclusione del proprio altro che rende inefficace il modello attuale. Anche il “modello alternativo” produce infatti un “luogo sacro”, che articola la casa secondo le esigenze dettate dall’evento pandemico, ma non da altro: un luogo dunque il cui significato daccapo prescinde essenzialmente dalla relazione con l’altro da sé.
E tuttavia da questa relazione nessuna cosa può prescindere. Nessuna cosa può stare da sola, né può farlo la casa. Abitandola, propriamente noi stiamo su una soglia, lì dove si incontrano l’abitazione e il suo altro: edifici, spazi aperti, prati, strade, eventi. Questo incontro è l’intreccio tra l’indivisibilità della casa nella sua unità e il suo dividere il proprio significato con l’altro da sé. La determinatezza dell’abitazione, di ogni abitazione, sta in relazione con l’altrui determinatezza e la include in sé come costitutiva del proprio esser così determinata.
Ma quale architettura è davvero capace di stare su questa soglia e di esprimere questo intreccio? Un’architettura che sappia costruire case che non sono semplicemente quel che sono, chiuse in se stesse e nella loro statica identità, e che configuri lo spazio in modo che sia strutturalmente aperto all’altro (per esempio ad altri interventi, o a differenti legami visivi e sonori con l’esterno).
Potremmo chiamarla l’architettura della casa che pensa. La casa che pensa non è una casa intelligente, cioè una casa che calcola. Ogni elemento del calcolo è infatti ancora qualcosa di indipendente dagli altri. È una monade senza finestre, come dice Leibniz. La casa che calcola mette in connessione i separati, dunque non può mai realmente connetterli, il separato essendo ciò il cui significato si costituisce non nella connessione, ma al di fuori di essa.
La casa che pensa è invece la casa che per materiali, tecnologie costruttive, flessibilità e modularità dei suoi spazi si lega al suo altro come essenziale al proprio significare. Essa non calcola, comprende. Include l’altro e in questa inclusione vive.
Francesco Ventura
Urbanista
Già Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze
Emanuele Lago
Filosofo
Fondatore e Ceo di ChiarAmEnte, Società che si occupa di progetti educativi per bambini e ragazzi da 1 a 14 anni
* Firmatari della lettera aperta: Professor Camillo Ricordi, Professor Ottavio Alfieri, Professor Michele Gallucci, Ramon Prat Homs, Giorgio Moretti, lo studio di architettura Archea Associati, Massimiliano e Doriana Fuksas
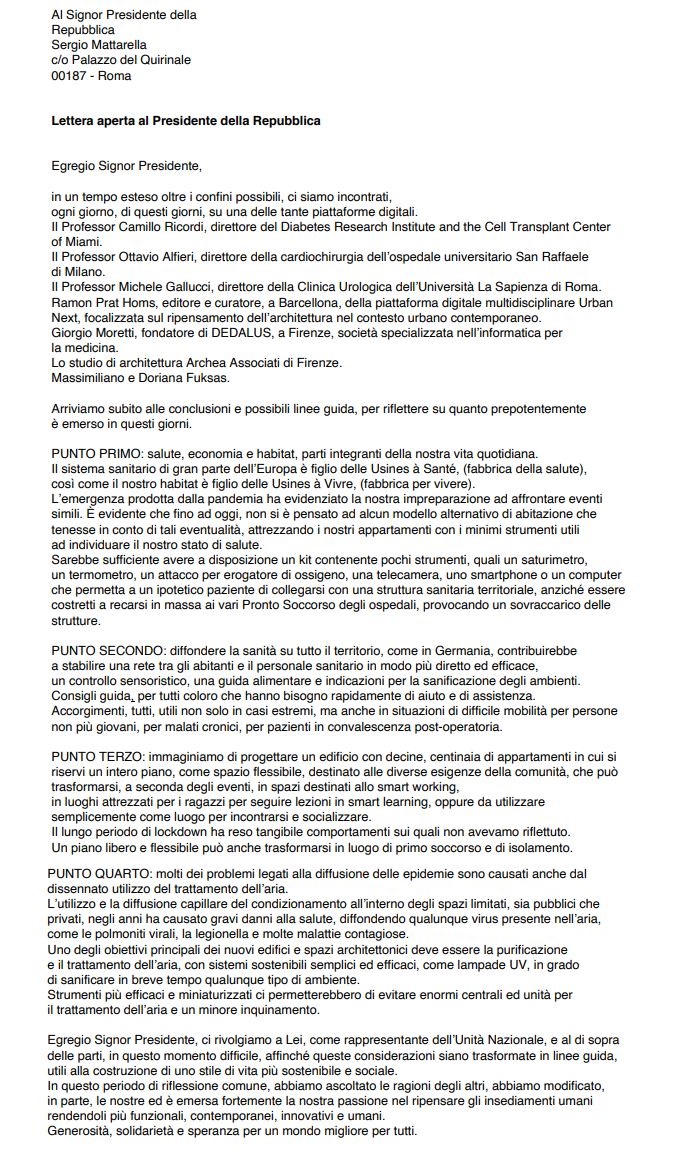
© RIPRODUZIONE RISERVATA
01 MAGGIO 2020 |
