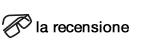
|
|
Hans-Ulrich Thamer, Adolf Hitler. Biografia di un dittatore, Roma, Carocci, 2021, pp. 318.
Sono un lettore attento di biografie e di autobiografie, peraltro, due generi letterari fra i quali intercorrono non poche differenze. Apprezzo, in particolare, quelle opere nelle quali gli autori riescono ad illuminare, insieme con la vita del (auto)biografato, anche i suoi tempi e il suo ambiente. Mantengo una certa distanza dalle introspezioni psicologiche anche se, talvolta, non abbastanza spesso, conducono a capirne di più del personaggio. In alcuni casi, però, specialmente quelli che definirò drammatici, le interpretazioni psicologiche hanno la tendenza a spiegare l’intero percorso di vita con la “socializzazione” del biografato e la sua devianza. Preferibili mi paiono le biografie che riescono a inserire il biografato nel suo tempo e nel suo luogo cercando di cogliere le strutture profonde, le influenze e quanto il biografato ne sia dipendente e/o abbia saputo plasmarle fino a, eventi eccezionali, dominarle. Fatta questa, credo, indispensabile, premessa, debbo ricordare che da tempo esistono alcune, buone, anche eccellenti, biografie di Adolf Hitler da quella pionieristica di Alan Bullock (1952) a quella sobria di Joachim Fest (1973) a quella possente in due volumi di Ian Kershaw (1998; 2000). Le ambizioni di Thamer sono più limitate, ma, anticipo, l’obiettivo di fondo, situare l’uomo e il capo politico nel suo tempo per comprenderne l’azione e valutarla, è conseguito più che soddisfacentemente.
Non è nelle origini familiari relativamente, ma non troppo disagiate, comuni a milioni di persone, neppure nelle vicissitudini scolastiche di uno studente certamente non modello, non motivato, non interessato a qualche materia specifica, infine, non di successo e non “popolare” fra i suoi compagni che si possono trovare gli elementi che costruiranno la leadership di un dittatore. Quanto all’antisemitismo era presente e diffuso in Austria, come in tutta l’Europa orientale, ma non in quantità allora esagerate e, comunque, inizialmente non dominanti nel pensiero e nelle azioni di Hitler. La svolta nella formazione politica avviene, sottolinea Thamer, con la Prima Guerra Mondiale. Hitler vi prende parte molto convintamente. Combatte, viene ferito, condivide l’interpretazione della sconfitta dovuta anche, sostanzialmente, alla “pugnalata alle spalle” inferta dalle sinistre tedesche, comunisti e socialdemocratici, alle Forze Armate tedesche. La sua visione negativa, ma non nichilista, viene rafforzata, quando è costretto a lasciare i ranghi militari e si trova senza lavoro. Forse, però, quello che conta maggiormente è che perde la sua comunità di riferimento. Noto che Thamer non menziona nessuna amicizia fatta da Hitler e non ritiene di esplorare se, quanto e come Hitler si rapportasse al mondo femminile tranne che, in generale, era misogino. Non è questione di poco conto poiché l’asocialità è, probabilmente, un elemento che spiega il disprezzo per la vita degli altri che il Führer manifesterà in tutta la sua vita politica. Spiega anche che non si consultasse con nessuno nelle decisioni importanti, che non chiedesse pareri e consigli. Solipsismo, secondo me, hubris, secondo il titolo che Kershaw dà alla vita di Hitler dalla nascita al 1936.
In effetti, in tutta la fase che va dal famosissimo tentato putsch nella birreria di Monaco, 9 novembre 1923, alla sua nomina a Cancelliere il 30 gennaio 1933, Hitler fece regolarmente affidamento sulla sua personale valutazione degli avvenimenti, dimostrando di nutrire la convinzione assoluta di non avere bisogno di nessuno nel perseguimento del potere: non solo arroganza, dunque, ma anche, questo mi appare il tratto dominante, fanatismo, non cieco, ma mirato, determinato, senza né tentennamenti né resipiscenze: “in vita mia” dichiarò lui stesso, “ho sempre giocato il tutto per tutto” (p. 223) . Più volte, Thamer sottolinea le grandi, rare e inusitate qualità oratorie e istrioniche di Hitler che dagli ascoltatori e dalle folle traeva energie elettrizzanti. I molti filmati disponibili costituiscono documenti indispensabili quanto inquietanti anche, forse soprattutto, per quello che a Norimberga e altrove ho sempre assimilato a un drammatico orgiastico sabba nazionalistico.
Il carisma trova conferma nella capacità di fare miracoli. Nel caso di Hitler i miracoli, sociali e economici, forse anche politici, avvennero dopo la conquista con la violenza e la manipolazione del potere politico nazionale. Tuttavia, bisogna interrogarsi sulla sua grande capacità di attrarre seguaci costruendo quella gigantesca macchina da guerra che fu il Partito Nazional-Socialista. Sulle macerie dell’impero tedesco, fra una popolazione disorientata, in un contesto attraversato da conflitti profondi e incomponibili, Hitler riuscì a sollecitare e a (ri)plasmare un’appartenenza nazionale basata su “sangue e territorio” e sull’identificazione del nemico, lo scrivo con qualche esagerazione e semplificazione: il bolscevismo ebraico.
Una questione sulla quale non sembra esserci accordo fra gli studiosi riguarda quello che chiamerò il progetto politico di Hitler e se questo progetto fosse già iscritto nel Mein Kampf (scritto in prigione e pubblicato nel 1925). Non vale in nessun modo la pena di confrontarsi con coloro che “leggono” Mein Kampf con gli occhi dei critici letterari e dei professori universitari, che fanno le pulci all’analisi e vi trovano errori di ogni tipo, soprattutto storici, come se si trattasse di una tesi di dottorato. Sarebbe bello se costoro leggessero sempre in questo modo i libri e le memorie dei politici, ma il punto è un altro. Da un lato, non è possibile esimersi dal notare che Hitler traeva molte delle sue idee da quanto già esisteva nella cultura tedesca, certo potremmo dire “deteriore”, ma non per questo meno diffusa e influente. Dall’altro, che Mein Kampf era da Hitler inteso, giustamente, come un documento di battaglia, peraltro, non necessariamente vincolante pur contenendo l’indicazione di molti degli obiettivi da perseguire, in particolare i più importanti: la conquista del potere politico e il fare grande la Germania. Se “Make Germany Great Again” richiama alle vostre orecchie e menti, cari lettori/lettrici, qualcosa di conturbantemente contemporaneo, ebbene: sì, proprio così. In corso d’opera, naturalmente sarebbe stato necessario disfarsi degli ebrei, ostacolo e nemici della grandezza che soltanto gli ariani potevano conseguire.
Rimangono tre punti importantissimi anche in chiave comparata per chi voglia capire come si costruisce e che cosa è un regime effettivamente totalitario. Alla luce di tutte le analisi, spesso “chiacchiere” su come muoiono le democrazie, è opportuno sottolineare quanto Thamer sostiene più volte con grande determinazione: senza la connivenza, il contributo, l’ipocrisia, la manipolazione e, buoni ultimi, gli errori delle classi dirigenti tedesche (p. 141), Hitler non avrebbe conquistato e mantenuto il potere. Questa osservazione vale a maggior ragione per Mussolini e per il fascismo. Dunque, non è vero che (tutte) le democrazie muoiono. Piuttosto, vengono uccise. Sempre conosciamo i nomi sia degli assassini sia dei loro complici. Secondo punto, una delle chiavi del successo di Hitler e del nazionalsocialismo fu il ricorso senza scrupoli alla violenza, spesso inaudita, fino al terrore. Domenico Fisichella merita di essere citato al proposito per la sua definizione dei regimi totalitari in base all’esistenza di un “universo concentrazionario” nel quale il terrore è l’asse portante, dominante. I campi di concentramento nazisti furono uno strumento cruciale per il regime, un esito non solo voluto, ma necessitato. Terzo punto: il regime nazista fu compiutamente un caso di totalitarismo realizzato (p. 171). Proprio guardando al nazismo governante coloro che posseggono gli strumenti del metodo comparato possono affermare con sicurezza che il fascismo italiano non riuscì mai a diventare, come tentò e sicuramente avrebbe voluto, totalitario.
In breve tempo, dopo il 30 gennaio 1933, Hitler privò di qualsiasi potere tutte le altre istituzioni, smantellandole. La strategia detta Gleichschaltung (uniformazione) fu attuata con successo totale. Nella Germania, un tempo ricchissima di associazioni, divenuta nazista, rimase un’unica organizzazione: il Partito nazionalsocialista in simbiosi con Adolf Hitler. “il Führerstaat totalitario, privo di controlli … sopravanzò in velocità con il radicalismo del suo sviluppo totalitario la dittatura fascista” (p. 171). Nell’Italia di Mussolini, persino negli anni che, impropriamente. Renzo De Felice chiamò “del consenso”, ovvero dopo la conquista dell’Impero, 1936, la Monarchia era rimasta viva e vitale, le Forze armate erano sabaude e nient’affatto fascistizzate, la Chiesa manteneva grande autonomia nell’ampio spazio assistenziale e educativo. Alla caduta di Hitler la “Germania anno zero” si presentò come una tabula rasa. Una volta licenziato Mussolini dal re, fu il Gen. Badoglio a guidare la prima transizione, mentre la Chiesa Cattolica si riposizionava senza difficoltà, utilizzando le molte risorse che mai le erano state sottratte. La conclusione di Thamer: “di Hitler non ci libereremo tanto in fretta” (p. 286) non suona affatto sorprendente per chi vive in un paese nel quale davvero il fascismo è “un passato che non passa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
15 OTTOBRE 2021 |
