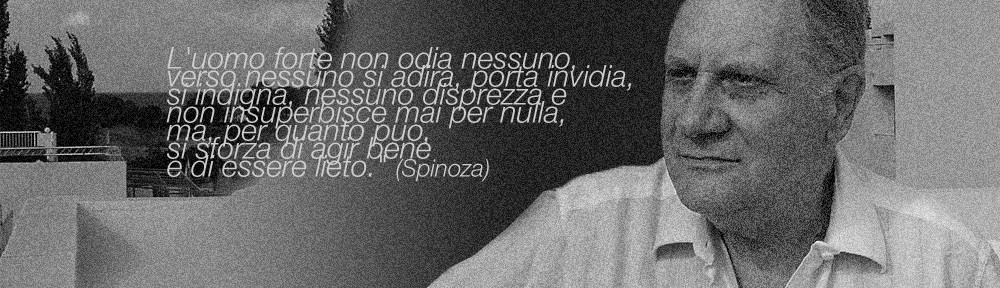La porta rossa di Ferruccio Capelli è davvero un piccolo grande libro. Scritto per celebrare i 70 anni della Casa della Cultura di Milano, ha il pregio straordinario di riuscire a far convergere in una storia molto particolare il senso e la trama di un intero orizzonte di vicende nazionali e internazionali che in questo lasso di tempo hanno attraversato e spesso anche sconvolto le nostre vite.
Si comincia, naturalmente, con le vicende dell’esordio, per molti motivi le più appassionanti, sia per i pochi che, magari giovanissimi, ne furono contemporanei o addirittura testimoni, sia per coloro che oggi ne sanno ormai pochissimo o meno di niente. Le radici della Casa della Cultura nascono infatti nel mezzo della lotta partigiana, come generoso e coraggioso progetto culturale elaborato durante la clandestinità da Antonio Banfi, Eugenio Curiel ed Elio Vittorini. Il progetto trova la sua realizzazione il 16 marzo 1946, quando Ferruccio Parri, ex comandante partigiano e ora primo Presidente del Consiglio della nuova Italia, inaugura la prima sede della associazione culturale. Essa trova espressioni parallele ed emblematiche nella famosa rivista di Vittorini, “Il Politecnico”, e nella rivista di Banfi “Studi filosofici”, vero crogiuolo per la formazione di giovani studiosi. Entrambe, scrisse allora Vittorini, sono l’espressione “di un umanesimo radicale e completo”.
In questa ammirevole formula sono già concentrate le virtù, le avversità e le fortune della Casa della Cultura. Un umanesimo di stampo illuminista, non retorico ma concretamente attivo su tutto il fronte della conoscenza e della scienza; radicale perché connesso profondamente con la lotta politica in favore delle classi lavoratrici e proletarie. Ma i tempi erano oscuri e non poco tempestosi. Capelli li rievoca con grande puntualità ed efficacia.
In senso internazionale, si diffondevano come tentacoli le ambigue e tenebrose vicende della guerra fredda; su scala nazionale spirava il cosiddetto “vento del Nord”, cioè il tentativo di realizzare nelle regioni settentrionali gli ideali più avanzati della guerra partigiana, con profondi quanto occasionali interventi nella società civile e nell’economia. La Casa della Cultura rappresentava il contesto culturale alto e magnanimo di questo impulso verso un reale rinnovamento della società italiana. L’opposizione dei ceti e dei partiti conservatori fu naturalmente fortissima, ma il punto decisivo accadde, come si sa, con la dura condanna del Partito Comunista, attraverso la rivista “Rinascita” e di Togliatti in persona: un movimento culturale che Togliatti e altri dirigenti del Partito giudicarono intellettualista, borghese, elitario, contrario agli interessi storici delle masse popolari, meglio rappresentati da una “cultura nazionale” che si richiamasse per esempio molto più a De Sanctis e a Labriola che non a Sartre e agli intellettuali parigini. L’esito fu disastroso: “Il Politecnico”, dopo l’uscita di Vittorini dal Partito Comunista, cessò ben presto di esistere e analogamente cessò le pubblicazioni anche “Studi filosofici”. Alla fine del 1949 la Casa della Cultura chiuse i battenti.
Riflettere su questa vicenda con il senno di poi è ovviamente facile, ma sarebbe ingenuo e soprattutto ingeneroso non tener conto delle difficilissime situazioni che travagliarono in quei decenni l’Europa, l’Italia e tutto il mondo industrializzato. Costretto a una ferrea dipendenza rispetto all’Unione Sovietica, circondato dalla reazione implacabile degli interessi capitalistici e dalle oscure manovre dei servizi segreti internazionali, obbligato a crescere sì esponenzialmente nelle occasioni elettorali, ma anche a controllare e stabilire certi limiti e modi di ascesa politica nel rispetto di strategie più grandi dei nostri orizzonti nazionali, il Partito Comunista non poteva che avvitarsi in una politica culturale spesso insincera, di mera facciata, di prudente ipocrisia e di continua allerta nei confronti delle sue stesse più creative avanguardie intellettuali. I necessari, o ritenuti tali, tatticismi, per esempio nei confronti della Democrazia Cristiana, non di rado prevalevano sulla libertà di espressione rivendicata dagli esponenti della cultura di sinistra. Forse non era allora possibile altra linea politica; certo fu proprio questa linea a segnare alla lunga la crisi e poi la rovina totale del massimo partito marxista in Europa: una catastrofe alla quale abbiamo assistito negli ultimi decenni e che oggi può dirsi totalmente, e anche amaramente, compiuta. Ma la Casa della Cultura si salvò.
Essa rinacque nel 1951, non senza l’interessamento indiretto dello stesso Togliatti e soprattutto per l’opera intelligente e accorta di Rossana Rossanda, giovane allieva di Banfi: troppo prezioso e urgente era il lavoro di diffusione critica e di innalzamento culturale che la Casa della Cultura aveva avviato a Milano, la capitale morale della giovane repubblica, innalzamento che era ancor più in grado di promuovere nel futuro. Naturalmente le scelte di fondo furono questa volta molto più elastiche, accorte e consapevoli; coscienti cioè dell’inevitabile divorzio che spesso si genera tra le esigenze immediate della politica e le visioni invece libere e lungimiranti della riflessione culturale. Cominciò così una nuova storia. Con una apertura a trecentosessanta gradi su tutta la cultura di stampo progressista, attraverso collaborazioni con il Piccolo Teatro, con la Scala e con i maggiori intellettuali italiani ed europei, la Casa della Cultura si impose come luogo di dibattiti liberi e spesso di qualità eccelsa, in mezzo alla sorda ostilità del mondo conservatore milanese e della stampa reazionaria del tempo, a cominciare dal “Corriere della sera” di quegli anni.
Ma una nuova tempesta era nell’aria ed esplose alla fine del 1956, quando i carri armati sovietici invasero Budapest. Ricorda Rossanda che quando l’ineffabile Alicata (che già si era segnalato nella prima condanna di Vittorini e Banfi) sostenne alla Casa della Cultura che a Budapest i russi stavano difendendo l’indipendenza dell’Ungheria, “dalla sala si alzò un ruggito”. I programmi della Casa della Cultura seppero far fronte alla nuova situazione che registrava la frattura drammatica delle forze politiche di sinistra. Per tutto il corso degli anni Sessanta i responsabili della associazione milanese continuarono la loro preziosa opera di costruzione e annodamento dei maggiori fili della ricerca culturale, in tutti i campi del sapere, delle arti e della letteratura e attraverso l’opera di grandi protagonisti che Cappelli descrive e ricorda al lettore con sapienza ed efficacia. Ormai era diventato chiaro che il programma della Casa della Cultura, nato dalla comune lotta antifascista, aveva proprio in queste radici il suo primo e il più durevole fondamento, che di fatto, nel corso dei decenni successivi, non venne mai smentito.
Capelli accompagna il lettore attraverso le vicende degli anni Sessanta e Settanta, dei cosiddetti anni del grande benessere e della crescita tumultuosa, sino al lungo crepuscolo del berlusconismo e al suo liberismo ingannevole e illusionistico; rievoca i contraccolpi nati dagli sconvolgimenti seguiti alla caduta del muro di Berlino e dagli anni di piombo sino all’odierna crisi economica e politica mondiale, tuttora assai virulenta. Le antiche figure degli intellettuali impegnati sono scomparse da tempo e la loro stessa funzione, negli scenari del presente, sembra essere diventata obsoleta. La politica si è sempre più ridotta ad amministrazione spicciola dell’esistente: quando non corrotta, essa è nondimeno miope o meramente pragmatica. Il divorzio della politica con la grande cultura è da tempo sotto gli occhi di tutti: l’unica cultura politica che persiste è quella volta alla cattura del consenso e alla esibizione mediatica. Poi ci sono i fenomeni della cultura di massa, mentre si impone la spettacolarizzazione di ogni iniziativa come condizione della sua stessa esistenza o supposta efficacia. Nel contempo le risorse per la cultura divengono ogni giorno più scarse e l’attenzione del pubblico più svagata, dispersa, frammentata e soprattutto, in larga misura, mercificata. Come può difendersi, in un simile clima, un’associazione come la Casa della Cultura? Come può tener fede alla sua storia e alle sue finalità morali e sociali? Come può sopravvivere materialmente (e il problema ha segnato momenti anche drammatici, per fortuna e per merito ampiamente superati)?
Ecco le domande che Capelli affronta con grande trasparenza e coraggio alla fine della storia che ha così calorosamente e precisamente narrato. La risposta ha un titolo quanto mai suggestivo e interessante; esso suona “Ritorno al futuro”. In sostanza: riportare nelle nuove condizioni del presente e del futuro quello spirito illuminista, quel razionalismo critico che fu l’ispirazione prima dell’intera impresa e la visione fondamentale dei suoi maestri. Si tratta di stare criticamente dentro il grande cambiamento; si tratta di riproporre quel nuovo umanesimo che fu, scrive Capelli, “l’antica lezione di Banfi, ovvero lo sforzo tenace per l’interazione con la cultura progressista dell’Europa e del mondo intero”. Di fronte agli innumerevoli temi e problemi del presente, di fronte ai vertiginosi progressi delle scienze, in particolare agli orizzonti futuri della biologia da una lato e dell’economia dall’altro, di fronte alle nuove sfide che nascono dai continui progressi tecnici della rete, di fronte agli esperimenti più desueti delle arti e delle lettere occorre rinnovare il metodo dell’analisi e della discussione razionale. Un programma audace e lungimirante e proprio per questo davvero attuale e a suo modo imprescindibile. Bisogna, dice Capelli, “contribuire a ricostruire una nuova enciclopedia della contemporaneità”. Formula e progetto a mio avviso esemplari. Essi evocano le radici “filosofiche” della modernità e le ripropongono come compito della cultura di tutti, di oggi e di domani. La Casa della Cultura, con la sua porticina rossa nel cuore di Milano, è ancora lì, fermissima, che chiama.