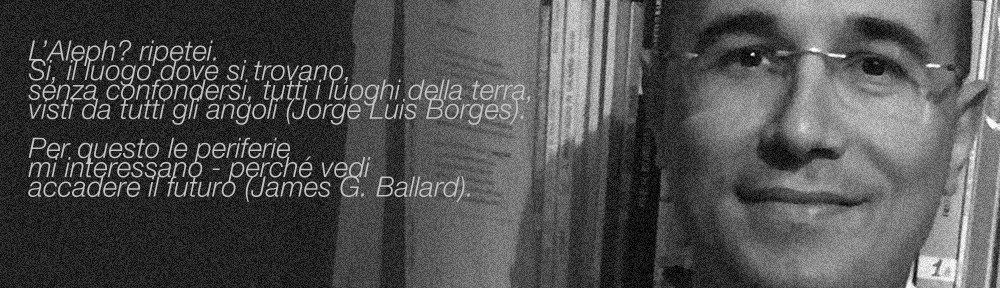(recensione di Spazi (s)confinati di Fabio Tarzia e Emiliano Ilardi)
Nella seconda stagione della serie tv Fargo compare Ronald Reagan che, in North Dakota nel 1979, sprona gli elettori verso una rinascita spirituale: «noi che abbiamo il privilegio di essere americani, abbiamo un appuntamento con il Destino da quel lontano 1630 in cui John Winthrop disse a quel gruppetto di pellegrini ‘Noi saremo come una Città sopra una Collina’». È indispensabile perciò che l’America «diventi quella Città luminosa sopra la Collina per una umanità inquieta e afflitta che guarda a noi».
Un discorso elettorale inframmezzato dalle immagini di una carneficina tra bande criminali rivali. E così lo sceriffo protagonista di Fargo, avvertendo il peso di una situazione difficile, chiede a Reagan: «crede che usciremo dalla crisi in cui siamo?». «Non c’è prova al mondo che un americano non possa superare». «Ma come?». Il candidato si volta ed esce di scena senza rispondere. Prima e dopo questa uscita di scena, nella serie tv e nella realtà, Reagan qualche risposta l’ha data. Subito prima, infatti, ha ribadito al racconto della guerra nel Vietnam fatta dallo sceriffo, citando un film di cui era stato protagonista nella sua carriera di attore, fondendo tragiche vicende e rappresentazione filmica, mostrando come attraverso l’immaginario si possa comprendere la realtà. Divenuto poi Presidente, eroe americano per eccellenza, Reagan ha indicato la direzione da seguire per «far ricominciare il mondo daccapo»: rimuovere gli ostacoli che il governo ha messo sulla strada degli individui e continuare la guerra al comunismo, intensificarla, vincerla anche attraverso il dominio garantito dallo scudo spaziale. In queste scene della serie tv e nell’azione politica di un Presidente è racchiuso tutto il motore della storia americana: l’immaginario e le sue diverse dinamiche.
Nel volume Spazi (s)confinati (manifestolibri, 2015, pp. 413), i sociologi della cultura Fabio Tarzia ed Emiliano Ilardi sostengono la tesi della centralità dell’immaginario nella storia degli Stati uniti e in tale ottica indagano quel «grande sistema comunicativo che, attraverso una strumentazione metaforica e allegorica, e un utilizzo del più svariato ventaglio di linguaggi, dà forma (attraverso i media) alle strutture culturali profonde e funge da mediazione tra queste ultime, gli individui e le trasformazioni storiche». Lo sconfinamento reaganiano tra il cinema e la realtà, l’attore e il politico dà conto di una forza dell’immaginario altrove storicamente molto più debole ovvero sostanzialmente alternativo rispetto alla realtà (quasi una compensazione rispetto ad essa). Ci pare perciò davvero apprezzabile il tentativo compiuto in Spazi (s)confinati di indagare il ruolo del fattore-chiave immaginario. E di farlo sganciandolo da quella critica tipicamente marxista che lo relega a mera sovrastruttura determinata e funzionale alle dinamiche dell’economia capitalista. L’immaginario – pur non essendo l’unico fattore del mutamento sociale così come per McLuhan non lo erano i media – gioca un suo ruolo autonomo e in forza di questa autonomia interagisce con altri fattori, tipo quelli economici, a volte indirizzandoli in determinate direzioni. Inoltre, coraggiosamente, i due autore indagano le dinamiche dell’immaginario americano nel lungo periodo, mostrandone splendori e miserie, momenti di gloria e crepe dall’arrivo dei Padri Pellegrini all’affermazione di Barack Obama.
Le parole e le azioni di Reagan ci mostrano, inoltre, come il sentimento di un «Destino Manifesto» derivato dal puritanesimo, da un lato, e la conquista dello spazio derivato dall’esperienza della frontiera, dall’altro, siano riconoscibili come le grandi matrici di sviluppo dell’immaginario yankee. Ciò dalla sua origine e sino almeno all’esaurimento della spinta propulsiva offerta dalle vittorie nelle due guerre mondiali. Poi qualcosa si è incrinato: il Vietnam ha forse rappresentato il momento in cui l’America è stata chiamata più che in altre occasioni a prendere atto delle crepe del suo edificio. Lo spazio della giungla asiatica non è stato conquistato e dunque neppure riconsacrato. Il nemico, che l’America ha sempre assolutizzato (dalle streghe ai «demoni» rossi, dai gialli vietcong ai terroristi islamici), non è stato punito. E molti figli della nazione eletta non sono più tornati alle loro case, nella loro Città sulla collina, se non dentro body bags. La nazione non è riuscita più a manifestare la sua elezione, la sua predestinazione, il suo Destino.
Una crisi che continua anche nella società globale di oggi, nella quale il ruolo degli Stati uniti non è ben definito, oscillando tra interventismo eccessivo e isolazionismo, rappresentazione del grande Satana e faro di democrazia. Dopo l’11 settembre e le guerre permanenti in Afghanistan e Iraq, non siamo più stati tutti americani. L’America non riesce più ad affermare la sua egemonia culturale prima che politica in un mondo multicentrico e turbolento. Un mondo in cui l’ibridazione con l’alterità è diventata la regola, non si riconosce più nel meccanismo di chiusura e apertura, di distinzione e conquista che l’immaginario americano ha dispiegato nel passato. Può l’America riconquistare un ruolo definito in questo mondo? Spazi (s)confinati non offre una risposta univoca; si limita a richiamare l’attenzione sulla capacità di reinventarsi che l’immaginario americano ha mostrato nel corso del tempo. Nella loro ricostruzione gli autori sostengono, tra l’altro, che in America non è mai emersa una sfera pubblica capace di mediare le diversità. Negli spazi sconfinati della frontiera al massimo si è manifestata una pubblicità senza sfera pubblica. In tal modo, però, non si avvedono di utilizzare un metro tutto «continentale» per interpretare un fenomeno che – come loro stessi mostrano – a quel metro non si può riportare. Non una sfera pubblica di tipo argomentativo o in generale costruita sulle grandi fratture ideologiche ma una sfera pubblica fatta di single issue, agitazioni emotive, filamenti di immaginario, forse effimera ma non meno significativa, ha improntato la politica negli Stati uniti. Su questa base non è escluso che gli States possano ritrovare un ruolo nell’epoca delle sfere pubbliche diasporiche che, come insegna Arjun Appadurai, sono giocate proprio sull’immaginario.
(apparsa parz. su il manifesto 20 marzo 2016)