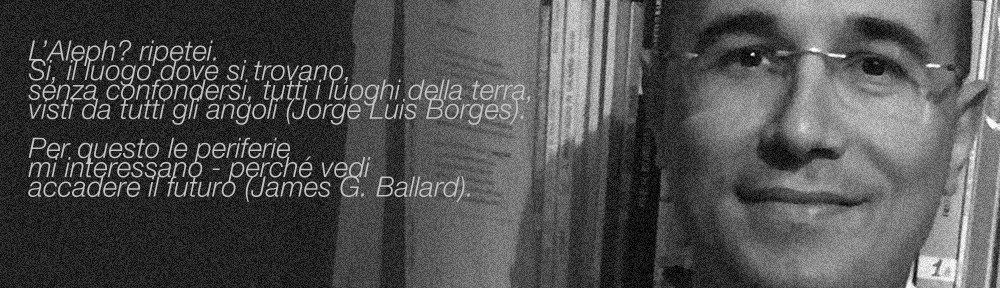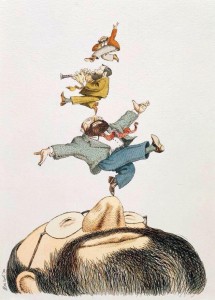Esistono tanti Umberto Eco. Tanti poiché tante sono state le sue attività e le sue stagioni. Tanti poiché tanti sono i percorsi e le passioni dei suoi lettori. Let me collect myself e riscriverlo attraverso due brevi testi a lui dedicati dall’angolo visuale di uno studioso dei nuovi media. Il primo è la voce “Eco, Umberto” scritta per i volumi sull’informatica e sulla cultura digitale dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani. Il secondo – inedito – scritto per la rubrica Non solo cyber de L’Espresso in seguito ad alcune sue bustine di Minerva. Insieme alla redazione concordammo poi di non pubblicarlo.
(Alessandria 1932) semiologo e romanziere. Dall’estetica medievale, Eco è passato ad analizzare i prodotti delle avanguardie artistiche e della cultura di massa. Un’analisi a cui si devono concetti che hanno avuto ampio riscontro nello studio dei media. Ancora oggi per descrivere le reazioni all’emergere di nuovi scenari culturali usiamo la distinzione tra apocalittici e integrati: per i primi la cultura di massa è l’anticultura, il “segno di una caduta irrecuperabile, di fronte alla quale l’uomo di cultura non può che dare una estrema testimonianza in termini di Apocalisse”, per i secondi essa “rende amabile e leggero l’assorbimento delle nozioni e la ricezione di informazioni, in un’epoca di allargamento dell’area culturale”(U. ECO, Apocalittici e integrati, Milano 1964, p. 4). Per almeno due decenni si poi è usata la distinzione tra paleo e neotelevisione con la prima che parlava o faceva finta di parlare del “mondo esterno” e la seconda che “parla di se stessa e del contatto che sta stabilendo col proprio pubblico. Non importa cosa dica o di cosa parli” (U. ECO, “Tv: la trasparenza perduta”, 1983, p. 163). Nel tempo della digitalizzazione delle forme espressive, e in particolare dell’ipertesto (>), è necessario più che mai confrontarsi con il fatto che ogni opera d’arte è sostanzialmente aperta a “una germinazione continua di relazioni interne che il fruitore deve scoprire e scegliere” (U. ECO, Opera aperta, Milano 1962, p. 60).
Ma l’impegno teorico principale di Eco è stato la delineazione di una semiotica generale come analisi di ogni forma di comunicazione (Trattato di semiotica generale, 1975) e la successiva identificazione del significato con una rete di rinvii. E da questo impegno viene fuori l’immagine chiave del pensiero di Eco; un’immagine di una certa utilità anche per descrivere lo spazio dei flussi telematici: l’enciclopedia. “Tutte le interpretazioni sono registrate, poste intersoggettivamente in qualche testo di quella immensa e ideale biblioteca il cui modello teorico è l’enciclopedia. […] Essa è l’insieme registrato di tutte le interpretazioni, concepibile oggettivamente come la libreria delle librerie, dove una libreria è anche un archivio di tutta l’informazione non verbale in qualche modo registrata, dalle pitture rupestri alle cineteche” (U. ECO, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino 1984, p. 109). È la grande biblioteca del romanzo di successo Il nome della rosa (1980). Ma questa stessa immagine segna anche il limite della comprensione di Eco del nuovo scenario culturale segnato dalle reti digitali e reticolari. Un limite che traspare anche dai continui distinguo di Eco riguardo alle forme espressive digitali e dalla sua difesa della tecnologia libro (Non sperate di liberarvi dei libri, Milano, 2011). Un limite che è quello proprio a un uomo di lettere, un homo tipographicus rispetto a fenomeni che vanno ben oltre la linearità delle lettere, che poco hanno a che fare con la cultura libresca.
Umberto Eco è intervenuto su queste pagine per stigmatizzare «i talebani del web» che, considerando la Rete come un mondo di sogni, un paese delle meraviglie, un paradiso virtuale, cosa dunque sacra e intoccabile, lo hanno accusato di essere apocalittico, luddista, misoneista per aver osato avanzare dubbi sulla marea di informazioni che ci sommerge tramite la Rete e rischia di soffocarci con inesattezze e bufale. Credo che l’obiettivo polemico di Eco sia ben individuato: nessun propugnatore di magnifiche sorti e progressive aiuta affatto le nostre sorti, soprattutto quelle legate alle nostre tecnologie (questo per ingenuità o per malafede).
Ho però avuto l’impressione che la critica del web avanzata da Eco muovesse da un assetto di pensiero pre-digitale, cioè non fosse all’altezza del compito assegnato: l’impressione di un uomo di lettere che critica qualcosa che va ben oltre la linearità delle lettere. Quasi come se dopo il Cinquecento si fosse continuata a criticare la politica sulla base della morale ancora cattolica o dopo il Seicento la ricerca scientifica sulla base dell’alchimia o dell’astrologia di Ermete Trismegisto. Una china, quella di adattare i fenomeni alle proprie categorie, che può addirittura portare a condannare la Rete «per intuito» e non sulla base di un confronto con la cultura digitale, la cui conoscenza «io non ho fatto e che, prometto, non farò mai», così Mario Tronti. Eco invece ha mostrato nel passato aperture importanti ai fenomeni emergenti. Siamo sicuri che saprà, anche a proposito della Rete, criticarla iuxta propria principia e cogliere in essa una pluralizzazione dei centri di storia che giova proprio allo sviluppo della capacità di sospetto.