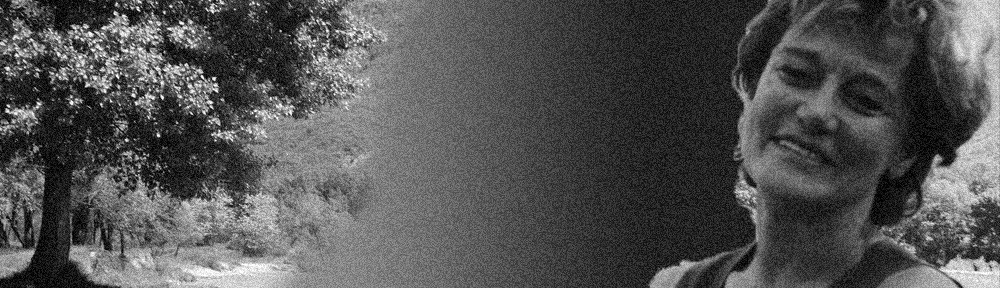Alla luce dell’esito delle elezioni americane il libro di cui parlerò, “Paranoie” di Fabrizio Gambini, risulta estremamente attuale. La vittoria di Trump non è forse dovuta anche alla paranoia sociale infiltrante, contagiosa, diffusa e che lui ha sollecitato? A cui ha promesso soddisfazione e rimedi adeguati in una specie di elogio della razza, americana e bianca. Chi mi legge giudicherà dal seguito se ho torto o ragione.
Ho trovato questo saggio appassionante per più motivi. Intanto perché esplora luoghi – i servizi di salute mentale – e riflette su soggetti – gli psichiatri e i loro pazienti – che ho frequentato quando ero molto giovane, tirocinante nei Servizi Psichiatrici delle Università di Roma prima e di Milano poi. Li’ mi allenavo ad apprendere il mestiere di psicoanalista, come era consueto fare per chi si voleva lacaniano: un tirocinio in psichiatria metteva l’aspirante analista a confronto con le psicosi paranoiche e la paranoia è, secondo Lacan, l’humus che alimenta il nostro “io”, l’identità che ci distingue e ci contrappone all’altro.
Ho fatto quindi un salto all’indietro nel tempo ripensando a quei primi anni di formazione e, al tempo stesso, mi sono interrogata sulla mia pratica attuale, perché le paranoie non si incontrano solo in istituzione ma sempre più spesso negli studi privati e, ancora di più, nei luoghi di consultazione, più accessibili degli studi privati, che alcuni psicoanalisti mettono in funzione. Come succede, ad esempio, nel consultorio dell’ALI a Milano, Edipo in città, dove chi si trova in difficoltà può trovare un orientamento anche se non ha formulato una vera e propria domanda d’analisi.
Ho letto il libro di Gambini tutto d’un fiato, durante un week-end, e, grazie a questo tipo di lettura, ho potuto apprezzarne il ritmo, la progressione delle argomentazioni, la costruzione, a tratti quasi pedagogica – lo dico con ammirazione perché non amo il linguaggio irrigidito del “lacanese” – delle tesi finali.
Gli interlocutori convocati sono molteplici: psicoanalisti, psichiatri, operatori, pazienti. Aggiungerei i comuni cittadini, potenziali elettori. Ho sempre pensato che un obiettivo peculiare della sinistra sia (o dovrebbe essere) quello di evitare la paranoia sociale e favorire piuttosto la tolleranza, il legame, l’accoglienza dello straniero ( e della straniera per antonomasia, cioè della donna). Se la paranoia vince la sinistra perde. Come negli States.
Il saggio dedica ai pazienti una quota notevole di simpatia intesa come la disposizione dello psicoanalista a essere preso, con il suo paziente, nel transfert e che in gergo psicoanalitico si chiama controtransfert. Che cosa significa?
Gambini dimostra con il suo stile, con il suo modo di presentare o alludere a un caso, che non si tratta solo di farsi coinvolgere nella domanda o di alleviare l’angoscia di chi ci sceglie come interlocutori, ma di una disponibilità preliminare, di una scelta: quella di chi assume una posizione di ascolto “benevolo”, privo di pregiudizi e sopratutto, cosa rara in una psichiatria dominata dai DSM (il manuale la cui prima edizione italiana è del 1980 e che è arrivato oggi alla V edizione), privo di ansia diagnostica.
Tanto per cominciare al rovescio, vado all’ultima parte del libro: il capitolo finale è dedicato alla psichiatria istituzionale ma parte da una domanda molto più generale che riguarda il nostro sociale e che dà per assodato che viviamo ormai in una società senza padri, senza che la funzione del padre venga occupata, in una società del tutto orizzontale come é stato spesso affermato in questi ultimi tempi. Gambini aggiunge qualcos’altro quando si chiede:
…é possibile una società senza padri che non esiti nell’appello ad un leader e che non sia diffusamente ed omogeneamente paranoica? (p.153).
Vale a dire: paranoia e totalitarismo vanno a braccetto, anche se il totalitarismo oggi può presentarsi sotto forme nuove. Qui l’attualità del libro risalta: la vittoria di Trump e gli argomenti della sua campagna elettorale sono una conferma di questa tesi. Gambini dà per scontati sia una tendenza psicotizzante nel nostro sociale (senza padri), sia una paranoia sociale diffusa e il rischio del totalitarismo.
In questo quadro, che definirei senz’altro politico e non solo clinico, l’Autore inserisce il proprio lavoro con la follia. E fa una denuncia e avanza una tesi: che ci sia il rischio che la follia venga “fabbricata” in ambito istituzionale. Tutto il libro è percorso da una critica costante, non aspra ma puntuale e senza sconti, alle modalità di presa in carico del paziente detto psichiatrico.
Gambini fa intendere al lettore che nel suo passato di psichiatra c’è stata la partecipazione al movimento di Psichiatria Democratica che, lo afferma con forza, non negava affatto l’esistenza della malattia mentale ma puntava il dito contro il funzionamento dell’istituzione manicomiale:
… ho finito, e ovviamente lo dico con un po’ di tristezza, per guardare ai Dipartimenti di salute mentale ( DSM) nello stesso modo in cui ho guardato al manicomio e non ho alcuna esitazione a dire che i DSM sono la nuova fabbrica della follia. (pp.154-55)
Da qui una serie di proposte a psichiatri ed operatori sulla conduzione della cura: la somministrazione di farmaci che tenga presente gli effetti diversificati per ciascun soggetto, la diagnosi fondata sull’ascolto e non sul fenomeno-malattia, un’attenzione al corpo del paziente che non sia di ordine medico per cui avere la psicosi sia l’equivalente dell’avere la varicella ma che tenga conto del soggetto che abita un corpo e che é un soggetto parlante.
È un invito ad abbandonare una posizione di difesa, di supponenza o di onnipotenza da parte di chi cura, per assumere la posizione, comune a tutti noi che parliamo, a noi umani, di esseri assoggettati all’Altro e al linguaggio, insomma assoggettati alla castrazione.
Conoscendo Fabrizio Gambini posso testimoniare che questa non è solo teoria o resoconto di una esperienza clinica, che pure sono preziose, ma corrisponde ad uno stile, ad un modo di essere e lavorare che lo caratterizzano come uomo, come psicoanalista e come psichiatra. Di questo stile fanno parte una certa, benevola ironia e la tolleranza verso se stesso e verso gli altri.
Detto questo si potrebbe credere che questo sia solo un libro di psichiatria innestata nel sociale. Non è così. E torno all’inizio: l’Autore costruisce un percorso che spazia dalla religione, al mito, alla letteratura, alla filosofia e infine alla teoria psicoanalitica per spiegare la differenza tra credere e sapere e per porre la Paranoia dal lato del sapere e della certezza e non dal lato della credenza, come avviene invece nel caso della religione. Il sapere e la certezza sono dal lato della paranoia (e della filosofia), la credenza dal lato della religione e della nevrosi ossessiva, come d’altronde sosteneva Freud.
Una delle tesi avanzate è che in un mondo in cui la forza della religione, della credenza religiosa in un Dio unico, si allenta – e questo non è senza rapporto con la “società senza padri” di cui dicevo prima – la paranoia cresce e assume forme nuove. L’affievolirsi della credenza religiosa sarebbe quindi in stretto rapporto con il diffondersi di nuove forme di sospettosità e con la convinzione che il nostro prossimo costituisca una minaccia.
In effetti, anche se non siamo pazienti psichiatrici, non diciamo forse che nelle nostre città siamo abituati a ignorare – dunque potenzialmente a temere – lo straniero – che quasi sempre è – il nostro vicino di casa? In genere non abbiamo la certezza della sua malvagità (non siamo paranoici in senso stretto), ma siamo abitati dal sospetto che la sua disposizione nei nostri confronti non sia esattamente amichevole. Così come la nostra nei suoi. In un rapporto duale e speculare, senza terzo e perciò aggressivo.
Quando il sospetto diventa certezza abbiamo un piede nella Paranoia. Questo tipo di delirio che riguarda il confinante non è raro da incontrare anche fuori dalle istituzioni psichiatriche e non solo, come nel caso dei vicini, a livello individuale, ma sociale. I muri che vengono innalzati da alcuni paesi per difendere i confini delle nazioni dall’arrivo dei migranti, sono il segno di una progressiva paranoizzazione sociale. “Sono imparanoiato” non è forse un’espressione entrata a far parte del gergo giovanile? La lingua registra l’emergenza sociale e individuale.
Dobbiamo quindi pensare che se nel discorso che esprime il nostro sociale Dio è morto, più niente è possibile?
Gambini ritiene, e in questo dissente da Lacan, che il trionfo della religione non segni lo scacco della psicoanalisi ma che il discorso psicoanalitico sia destinato a convivere con altri discorsi. Anzi che la psicoanalisi abbia un compito particolare: parassitare gli altri discorsi…minarne la durezza, temperarli…
In effetti l’operazione di questo libro e la pratica che gli sta dietro vanno in questa direzione. Il discorso della psicoanalisi parassita il discorso psichiatrico, ne mina la durezza, lo tempera, bilancia l’assenza di credenza che ci fa correre il rischio di diventare paranoici.
Se capisco bene il senso complessivo dell’operazione di questo saggio, la psicoanalisi e il suo discorso avrebbero una funzione di mediazione e anche di difesa dalla follia. In questo senso bisognerebbe infiltrare, direi, la presenza degli analisti negli ambiti sociali e di ricerca e ovunque un altro discorso, che sia religioso, o peggio, scientifico, tenda ad imporsi.
In conclusione, il libro testimonia dell’uso della psicoanalisi in psichiatria, delle novità che introduce e delle risorse che può mettere in campo nelle attuali “fabbriche della follia” se viene utilizzata con saggezza, competenza e passione. Ma suggerisce molto di più sul nostro mondo di normali paranoici in cui un personaggio come Donald Trump può essere eletto alla guida del più potente paese del mondo, che in maggioranza si identifica con lui e che perciò egli può, del tutto legittimamente, rappresentare.
Fabrizio Gambini, Paranoie. Tra psichiatria e psicoanalisi, Saperci fare con la psicosi, Franco Angeli 2015