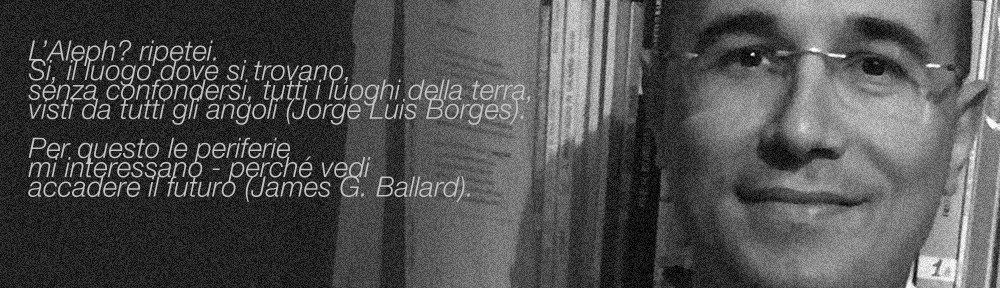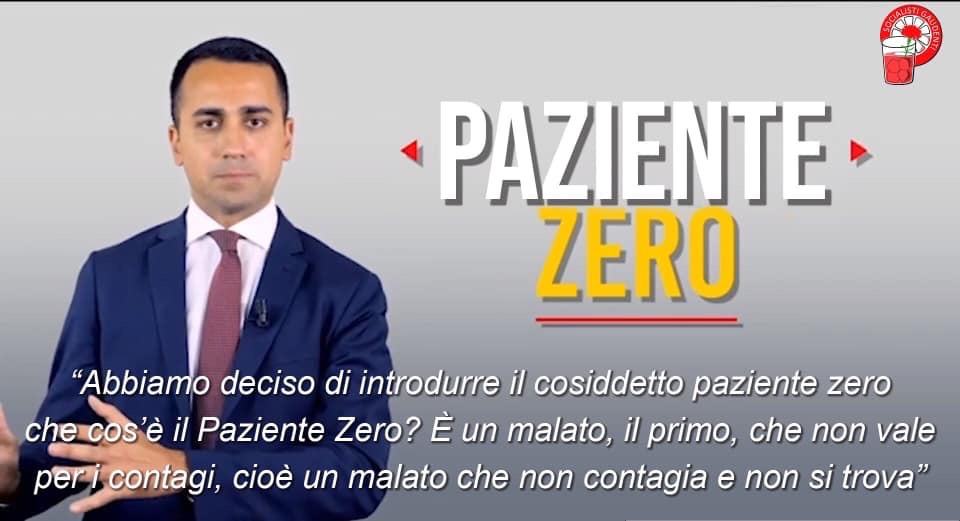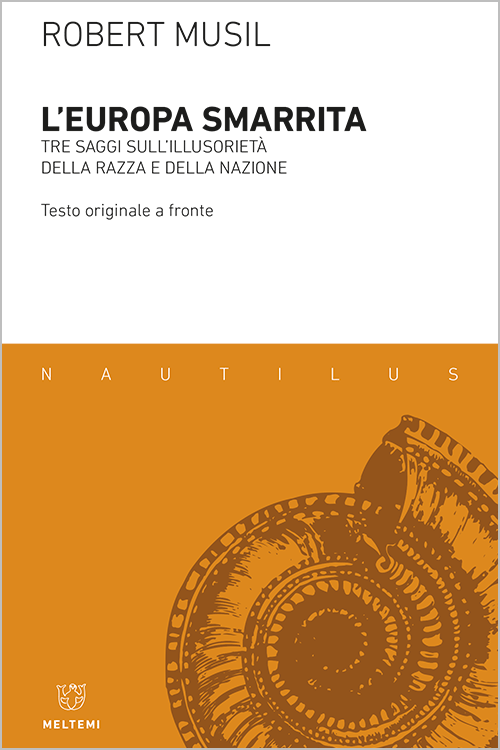(recensione di I mille volti di Anonymous di Gabriella Coleman)
Un libro per raccontare tattiche e strategie della presa collettiva di parola che si afferma attraverso l’hacktivism: l’azione diretta in rete
Anonymous, la maschera collettiva degli hacktivisti più famosi al mondo non smette di far parlare di sé. Tuttavia, dalle operazioni contro la Sony alla solidarietà manifestata a Julian Assange, forse non si è ancora riflettuto abbastanza sul significato politico di un fenomeno, ormai globale, che riassume sotto il proprio nome teorie, strumenti e pratiche dell’underground dalle origini della rete fino ad oggi.
 Il volume I mille volti di Anonymous: la vera storia del gruppo hacker più provocatorio al mondo (Stampa Alternativa, Viterbo, 2015, pp. 473, euro 24,00) dell’antropologa Gabriella Coleman, offre questa occasione. Nel libro, l’antropologa, embedded per diversi anni nel gruppo degli Anon, enuclea infatti il racconto avvincente di una serie di operazioni che hanno contrassegnato “la metamorfosi di Anonymous dal mondo sotterraneo dei troll fino all’attivismo pubblico”. Dalle bravate e dagli sbeffeggiamenti via internet si passa presto allo scontro con la chiesa di Scientology per arrivare, infine, all’emergere di un nuovo soggetto politico, di un quinto potere che interviene in situazioni globali e locali, dalla difesa di Assange all’aiuto operativo ai giovani della Primavera araba. Sempre senza nome, nascondendosi dietro la maschera del celebre rivoluzionario inglese Guy Fawkes che, tra Cinquecento e Seicento, sfidò la monarchia britannica e che il film V per Vendetta dei fratelli Wachowsky ha riscoperto e riaggiornato all’inizio del nostro secolo, giusto prima della nascita di Anonymous.
Il volume I mille volti di Anonymous: la vera storia del gruppo hacker più provocatorio al mondo (Stampa Alternativa, Viterbo, 2015, pp. 473, euro 24,00) dell’antropologa Gabriella Coleman, offre questa occasione. Nel libro, l’antropologa, embedded per diversi anni nel gruppo degli Anon, enuclea infatti il racconto avvincente di una serie di operazioni che hanno contrassegnato “la metamorfosi di Anonymous dal mondo sotterraneo dei troll fino all’attivismo pubblico”. Dalle bravate e dagli sbeffeggiamenti via internet si passa presto allo scontro con la chiesa di Scientology per arrivare, infine, all’emergere di un nuovo soggetto politico, di un quinto potere che interviene in situazioni globali e locali, dalla difesa di Assange all’aiuto operativo ai giovani della Primavera araba. Sempre senza nome, nascondendosi dietro la maschera del celebre rivoluzionario inglese Guy Fawkes che, tra Cinquecento e Seicento, sfidò la monarchia britannica e che il film V per Vendetta dei fratelli Wachowsky ha riscoperto e riaggiornato all’inizio del nostro secolo, giusto prima della nascita di Anonymous.
Anonymous, una nuova forma di partecipazione politica
Coleman durante il racconto mette in evidenza diversi temi interessanti legati alle azioni di Anonymous. Uno in particolare ci pare decisivo per comprendere le dinamiche politiche contemporanee e in particolare quelle legate alla partecipazione politica. Le azioni di Anonymous paiono fornire una sorta di soluzione a un’impasse teorica a cui conducono diverse analisi dei processi partecipativi nel tempo della Rete.

Da un lato, è facile cogliere nelle nuove piattaforme comunicative un allargamento dei repertori di azione a disposizione dei singoli e dei gruppi per intervenire nella sfera politica. Forum, petizioni, blog e tutti i siti di social networking offrono a ciascuno la possibilità di prendere parola sulle vicende politiche locali o globali. Dall’altro lato, pare che questa presa di parola non si traduca sempre in effettiva capacità di incidere sulle scelte compiute dalle autorità: quasi che la parola dei cittadini, sempre più diffusa, nello stesso tempo si sia allontanata, sempre più, dai centri della decisione. In altri termini, all’allargamento della partecipazione come opinione non corrisponderebbe un approfondimento della partecipazione come decisione.
Dai defacement ai DDoS al doxing: le tecniche di Anonymous
Per far parte di Anonymous è necessario un processo di socializzazione alle dinamiche del gruppo e in particolare alle sue modalità operative. Ciò non comporta, però, la necessità di divenire hacker professionisti per partecipare a tutte le operazioni messe in campo. Diverse ed eterogenee sono infatti le tattiche a cui si è fatto ricorso, alcune richiedono capacità tecnologiche elevate, altre poco sofisticate, alcune sono pienamente legali, altre sconfinano nell’illegalità. Si va dal defacement di siti web al loro blocco temporaneo tramite attacchi DDOS, dal reperimento tramite incursioni informatiche di documenti riservati e pubblicamente rilevanti alla loro divulgazione, dal doxing di informazioni personali al file sharing di prodotti sotto copyright, dall’email spamming alle tradizionali proteste di piazza.

La metamorfosi di Anonymous dal mondo sotterraneo dei troll fino all’attivismo pubblico
Un elemento sembra accomunare tutte queste forme di intervento: pur trattandosi (eccetto, naturalmente, le proteste di piazza) di impegni tramite la tastiera e il linguaggio informatico, esse possono essere classificate come azione diretta. Non si tratterebbe, cioè, di far semplicemente sentire la propria voce ma di imporla con cogenza sino a determinare cambiamenti concreti delle decisioni prese (dalle politiche di importanti aziende alla riapertura di indagini giudiziari, passando naturalmente dal cambio di regime politico seguito all’#OpTunisia). In questo caso, cioè, il linguaggio (digitale) si rivelerebbe pienamente nel suo aspetto performativo, producendo effetti diretti sul mondo della vita (come indicato da Austin e facendolo in maniera non normativa, al contrario del “potere comunicativo” di Arendt e Habermas).
Si tratta di nuove forme di intervento nello spazio dei media, sia nuovi che vecchi (reclamando attenzione mediatica), che si pongono come tattiche “deboli” di intervento nella sfera politica della decisione. Non bisogna fare l’errore di sopravvalutarne l’apporto ma può essere utile coglierne il valore di modello di azione che va oltre, da un lato, la mera espressione di opinione e, dall’altro, quei modelli moderni – come il voto – che sono sempre meno riconosciuti come adatti a garantire l’intervento nella dimensione politica nel nostro tempo postmoderno.
[apparso su Cyber Security, 27 ottobre 2016, <http://cybersecurity.startupitalia.eu/53182-20161027-defacement-ddos-doxing-mille-volti-anonymous>]