Il libro* è una raccolta di saggi di autori di competenze diverse (scrittori, psicanalisti, sociologi etc.) pubblicato nel 1996, cioè prima dell’ondata di terrore e di paranoia prodotta dagli attentati sanguinosi delle Torri gemelle di NY nel 2001 e dalle stragi di cittadini inermi avvenuti in questi ultimi anni: da quella di Charlie Hebdo a Parigi al boulevard des Anglais a Nizza. La Francia, la nazione più colpita, è anche il luogo di provenienza culturale degli autori, il paese in cui la questione islamica è molto sentita e studiata, in cui c’è un ampio ventaglio di intellettuali che se ne occupa, in cui l’immigrazione, soprattutto dai paesi del Maghreb, è presente ormai da almeno tre generazioni ; dove perciò la frizione culturale e sociale è più forte.
Malgrado preceda i drammi provocati dagli attacchi dell’ISIS, il libro non è affatto invecchiato: le questioni che pone sono attualissime e non solo irrisolte ma inasprite per le ragioni appena dette, per il risveglio di sentimenti di paranoia, razzisti, segregativi che quegli avvenimenti hanno prodotto. Ma circoscriviamo il problema per porcelo così come fanno gli autori: che cos’è essere un uomo nei paesi islamici? Per la verità la domanda sarebbe pertinente anche da noi. Non a caso l’ultimo numero della rivista”La clinique lacaniene”, appena uscita, ha come titolo “Qu’est-ce qu’un homme? “. Dunque la questione della virilità e del “che cos’è un uomo” (questioni diverse ma confinanti) sono estremamente attuali.
La questione della virilità in Islam, ma anche quella importata nei nostri paesi d’accoglienza come un valore identitario da difendere a ogni costo, è una questione centrale che non riguarda solo la reazione tra i sessi ma anche l’organizzazione politica e sociale intera. Giustamente nella sua Introduzione Benslama e Tanzi fanno notare che le analisi che si sono sviluppate da quindici anni a questa parte (oggi 35 anni) sono tutte focalizzate sulla condizione di vittima della donna islamica ma non si occupano delle determinanti sociali e psichiche della virilità nei paesi arabi così come del suo legame con le componenti teologiche e antropologiche.
Potremmo dire altrettanto per le analisi che vengono fatte da noi in Occidente per comprendere gli episodi di violenza sulle donne: analizzano il ruolo delle vittime e insorgono contro i casi di maltrattamento ma non si occupano, o si occupano poco, di come si ponga la questione della virilità oggi. Ci sono molte ricerche e studi sulla femminilità ma pochi sulla virilità e le sue difficoltà.
Quest’affermazione, la scarsità di studi e ricerche sulla questione, non sminuisce la portata del problema delle donne-vittime di violenza che, per fortuna solo in casi di eccezione, riguardano anche l’Occidente, ma vuole solo sottolineare la scarsità dei contributi dati all’esame della questione dell’identificazione virile. Questione centrale perché l’attuale precarietà dell’identificazione virile è appunto alla base di moltissime forme di violenza.
Il libro contiene alcuni saggi che a noi, ormai privi di riti e usanze, appaiono”colorati”, ad esempio quello di apertura di Adel Faouzi sulla prima notte di nozze; una descrizione che però non è solo folklore, come ci potrebbe apparire:
A noi sembrano usanze barbare – e in effetti lo sono, probabilmente anche per gli uomini che devono agirle- ma non poi molto lontane da quelle di talune comunità del Sud dell’Italia degli anni cinquanta. Sottolineo che la somiglianza riguarda i “comportamenti “, perché le referenze culturali sono diverse nell’un caso e nell’altro, in Occidente e in Islam ; sono però in entrambi i casi comportamenti che rinviano a una concezione arcaica della funzione maschile in cui l’interesse per le donne si dimostra attraverso la provocazione, l’insulto, il complimento greve, il corteggiamento pressante (quello che oggi chiameremmo stolking) e che rende le donne intimidite, paurose ma al tempo stesso le designa come oggetto di desiderio (anche se un oggetto degradato e ridotto alla pura fisicità).
A questa modalità le donne finivano -nel nostro Sud almeno, fino agli anni Cinquanta- per aderire, vi si conformavano in quanto modalità sociale di approccio da parte dell’altro sesso. Questi saggi, più descrittivi che teorici, vanno letti e meditati perché non concernono l’arcaico -come i vecchi film in bianco e nero girati tra culture contadine- ma riguardano la realtà, ancora viva, di una grossa fetta del nostro mondo, di una certa cultura legata all’Islam.
Ma il “machismo” ha davvero a che fare con l’Islam?
In questo consiste grossa parte dell’interesse, secondo me, di questi saggi: i comportamenti “machisti” presentano uno scollamento rispetto alle stesse radici culturali che vorrebbero testimoniare. Sembra infatti che la religione islamica, nei sui testi fondatori, non abbia niente a che fare con questa esibizione di virilità violenta, di disprezzo del sesso femminile, di guerra radicale portata contro il cosiddetto “nemico”, nella fattispecie l’Occidente e i suoi valori corrotti.
Nella sua introduzione giustamente Angelo Villa fa notare che dietro queste manifestazioni c’è una evidente confusione, diciamolo ex abrupto-, tra fallo e pene. Tra funzione simbolica del fallo, funzione regolatrice del politico, del sociale e dello psichico e funzione immaginaria del pene. Che il fallo viene confuso con l’avere l’organo e che l’avere l’organo e dimostrare che funziona diventa il segno per eccellenza della virilità.
In questo senso, potremmo forse azzardare che questa confusione di reale e simbolico, di registri del reale e del simbolico, del pene col fallo, è qualcosa che oggi accomuna la cultura occidentale e la cultura araba: entrambe, in realtà, sono marcate da questa indistinzione, dall’evanescenza di una funzione regolatrice, quella che noi lacaniani chiamiamo funzione Nome del padre.
In entrambi i casi abbiamo infatti a che fare con l’evanescenza di un registro (il simbolico) e con la ricerca in un organo che fa segno, l’organo reale, il pene, dunque con una regolazione impossibile. Nessun immaginario può costituire un ordine, una regola, un referente centrale. Neanche, evidentemente, un organo che, in quanto tale, può fare da supporto alla funzione simbolica ma non essere al posto della funzione regolatrice e simbolica.
Benslama, psicanalista e islamista notissimo in Francia, scrive un saggio che si chiama: “Il velo dell’Islam “in reazione alle polemiche sorte a proposito del velo che alcune giovani di origini maghrebine intendevano portare, soprattutto a scuola. Benslama difende un punto di vista che si distacca dal modo tradizionale della discussione: o integralismo o integrazione, o/o, o l’uno o l’altro.
Non si tratta di contrapporre le due cose: sostenere la necessità che immigrati di altre culture accettino di entrare nelle norme, costumi, insomma nel discorso del padrone (per usare ancora il gergo lacaniano) del paese di accoglienza per mimetizzarsi nel mondo che li ha accolti oppure difendere in modo integralista – e con le derive che conosciamo- la cultura d’origine. Si tratta invece di spostare i termini del problema.
Le tesi di Benslama convergono sulla questione del velo delle donne. Oggi probabilmente la questione è sopravanzata dagli orrendi crimini di sangue avvenuti in nome dell’Islam e spogliata del suo valore simbolico anche perché talvolta il velo è stato usato proprio per camuffare degli attentatori o per sfuggire alla sorveglianza delle polizie (è il caso delle donne kamikaze o degli uomini travestiti da donne). Benslama riprende la discussione velo si/ velo no e dice che, dal punto di vista della teologia islamica, il velo non fa segno ma copre qualcosa che fa troppo segno, cioè il corpo della donna. Il corpo della donna va velato perché non si segnali troppo. Il corpo della donna fa “macchia” e la macchia va quindi dissimulata. Tuttavia, sempre secondo la teologia islamica, questa funzione di macchia si accosta alla funzione della verità e costituisce, per l’uomo, una rivelazione. Tutto questo si è ormai, dice Benslama, rovesciato nella diffidenza verso la donna e per questo bisogna velarla perché, direi, proprio come la verità, non faccia macchia. Quest’accostamento tra la donna, la funzione della macchia e la funzione della verità nella teologia islamica mi è sembrato molto importante perché dà alla donna un posto e una dignità che non hanno niente a che vedere col delirio jaidista.
Jacques Hassoun, psicanalista, si interroga invece sul genere del termine: come mai si dice “la “virilità? La questione è poco affrontata dai dizionari dove si fa valere l’etimo, il latino “vir” che è anche il prefisso di “virtus” la forza necessaria ad affrontare le difficoltà per raggiungere uno scopo. Al centro delle preoccupazioni degli uomini sono la virilità e la capacità di generare ma non il diventare padri -questione simbolica molto più complessa appiattita oggi sulla capacità generativa reale anche a causa dell’applicazione delle nuove tecnologie mediche alla procreazione (PMA); vale a dire cioè che l’attenzione è portata più su una questione biologico-naturale, dunque reale, che su una funzione simbolica.
L’idealizzazione della virilità, intesa come forza imbattibile e assoluta, va invece in direzione opposta al desiderio perché esso nasce dalla mancanza e dunque dalla castrazione. L’idealizzazione della virilità è contro il desiderio di un uomo per una donna. In questo senso, cioè contro il desiderio per la donna, sembra andare tutta la corrente deteriore dell’Islamismo oggi.
È dunque la virilità ferita, privata del suo valore simbolico, del suo posto e funzione, che produce crimini, vendetta e violenza? È una virilità ridotta al suo reale, a un organo, a qualcosa non che significa (e che rinvia dunque a una pluralità di significazioni) ma fa solo segno: c’è un organo, c’è un pene dunque ci sarebbe un uomo.
Quest’equivalenza produce un “effetto banda” vale a dire un’adesione alle prediche degli apprendisti dittatori che incitano al combattimento e alle virtù dell’eroismo e della virilità.
Non è forse un effetto simile a quello che si produce da noi negli stadi? O nelle bande giovanili? O nei quasi-bambini che aggrediscono i loro coetanei nei quartieri degradati di Napoli? Con la differenza che nei paesi islamici il tentativo è di fare di queste bande ciò che regola una comunità, una regola che sarebbe garantita dalla religione e dalla tradizione. Tutto questo mi sembra una proliferazione d’immaginario, disordinata e caotica, che prende tanto più piede quanto più l’apparato simbolico non risponde. Questo tratto, fragilità del simbolico e proliferazione dell’immaginario a partire dal reale, accomuna, con le dovute differenze, l’Occidente e l’Islam così come sono oggi. È una somiglianza che potremmo definire effetto della globalizzazione e che mi sembra, se non più grave, quantomeno altrettanto urgente del conflitto e della contrapposizione tra mondi e culture diversi per cui dobbiamo trovare soluzioni sostenibili e non banalmente razziste da un lato e integraliste dall’altro. Soluzioni vecchie in cui ci rifugiamo per molti umani motivi, ma inutili, inefficaci e per giunta dolorose.
LA VIRILITA’ NEll’ISLAM*
di Fethi Benslama e Nadia Tanzi
Poiesis edizioni 2018
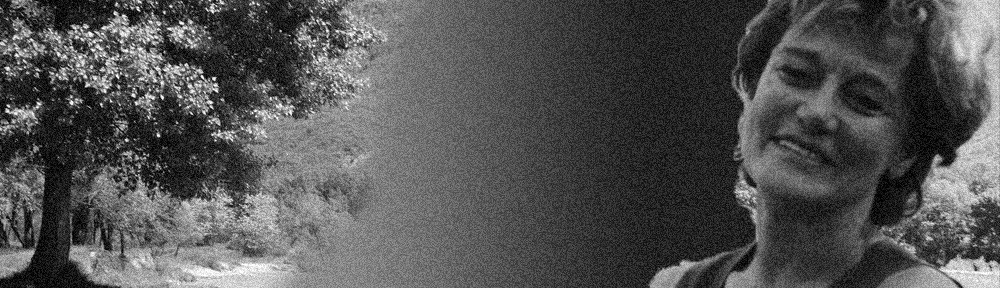





 lla ricerca di un figlio?
lla ricerca di un figlio?