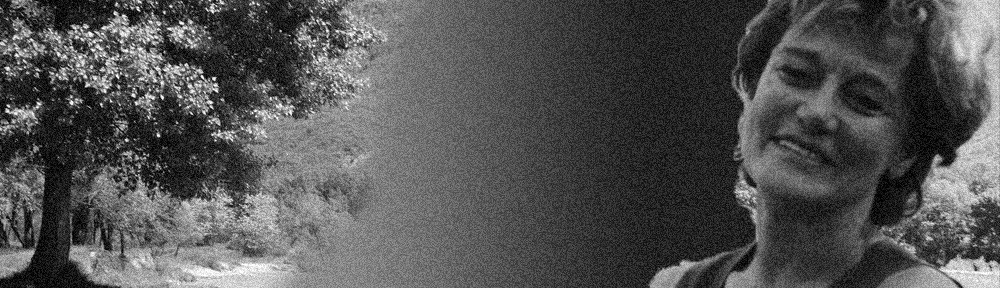Quando, per una ragione o per l’altra – film, mostra, teatro, un amico appena arrivato- un pezzo di Napoli sbarca a Milano, osservo curiosa e intenerita il suo impatto sulla gente. Anche se ormai Totò, Eduardo, la nuova cinematografia, la tv hanno reso familiare la cantilena dolce e a tratti aspra e aggressiva del napoletano, quel dialetto fa buco perchè racconta un mondo che resta diverso, malgrado sia immerso nel mondo universale delle merci. Napoli ci sorprende come un paese straniero, se è ben raccontata.
Così è successo per il film di Leonardo Di Costanzo, L’intrusa, presentato di recente dallo stesso regista e dal critico Paolo Mereghetti al cinema Anteo. Un regista schivo e avaro di parole per lasciare, come ha detto, agli spettatori la sorpresa contenuta in quello scampolo di periferia di Napoli che fa da scenario al film.
L’intrusa è la giovane moglie di un camorrista assassino che si rifugia – e il marito con lei ma resta ambiguo se ci sia o meno un patto fra di loro – in una ex masseria diventata un luogo di accoglienza, di gioco e creatività per i bambini del quartiere e gestito con l’obiettivo di creare legami civili, gentili, rispettosi, umani insomma, fra i bambini, tutti i bambini della zona, senza esclusioni. Questo nobile progetto, -che procede come in una corsa a ostacoli, precario come Mister Jones, il surreale montaggio in ferraglia che si muove su ruote di vecchie biciclette, costruito dalla combriccola di operatori e bambini per la festa finale- si interrompe con l’arrivo dell’intrusa e dei suoi due bambini, un neonato e una bimba di circa nove anni dotata del piglio, della sfrontatezza e dei saperi adulti che tanti bambini dei « quartieri » o delle periferie hanno a Napoli ; al tempo stesso però intrisa di ingenuità e di voglia di gioco, come qualsiasi bambina.
La comunità respinge questo piccolo nucleo familiare, arrogante e fragile, che pure in un primo momento era stato accolto, dopo che la polizia fa irruzione per arrestare l’assassino che essa nascondeva, all’insaputa di tutti. Le mamme portano via i loro bambini, la scuola non invia più i propri alunni, la struttura si svuota.
Il finale sarà agro-dolce ma lo taccio per non guastare la visione a chi mi legge.
Tutti i dialoghi sono sottotitolati perché gli attori parlano in napoletano: non il napoletano scandito della tv o quello un po’ italianizzato alla Troisi, per intenderci, ma il dialetto (la lingua?) che usano correntemente nella realtà: affrettato, precipitoso, urgente, ricco di sonorità. E incomprensibile per i più. I sottotitoli in italiano, come nei film in lingua straniera, creano un effetto di distanza e di simpatia al tempo stesso per quel piccolo universo, per i protagonisti, straordinari attori presi dalla strada e plasmati egregiamente dal regista.
La responsabile della struttura, la sola che parli sempre in italiano, è un personaggio integro, mosso da un’istanza civilizzatrice e morale, in contrasto con le contraddizioni, la varietà, l’imprevedibilità di tutti gli altri, sopratutto della giovane intrusa e della sua bambina. Loro sono la Napoli dei quartieri, un’altalena di rabbia e voglia di integrazione, arroganza e dignità, prepotenza e auto-esclusione, sincerità e inganno.
Durante la presentazione è stato detto che il film, neorelista, ricordava la poetica dei fratelli Dardenne. Infatti è stato premiato al festival di Cannes: a giudicare dal numero dei turisti che affollano la città in ogni stagione, i francesi amano Napoli e la sua fantasiosa creatività.
Il film contiene momenti di pura poesia come la scena, girata di notte, in cui la bambina accompagna la madre, cingendole la vita con aria protettiva, a scaldare di nascosto il latte per il suo piccolo piangente e affamato. Un rapporto capovolto tra madre e figlia condito a tratti da una specie di pietas precoce e consapevole.
E’ il racconto di un frammento di Napoli oggi, una poesia senza fronzoli che racconta come stanno le cose: la malavita mescolata alla vita comune, la fame che non rispetta la proprietà privata, la dignità di chi non ha niente da perdere, la menzogna di chi crede di non avere scelta. E la generosità, la cordialità, il gusto del vivere. C’è anche il mondo perbene e razzista, la ( piccola) borghesia che non vuole farsi contaminare dalla parentela mafiosa, foss’anche di un bambino.
Paradossalmente questa presa di distanza dalla delinquenza (della scuola, delle famiglie degli alunni, di qualche operatore) mostra un altro volto di Napoli: non più straniera, nè generosa, nè aperta ma ottusa e paranoica come ogni metropoli. Questo è il punto di torsione che il registra ci mostra: Napoli non può reggere a lungo il cartellone dell’ umanità se il mondo intorno è cosi mutato. Resta però l’estraneità della lingua, viva e vitale, parlata dalla gente, a differenza di altri dialetti. Basterà a preservere l’esistenza di questo angolo di umanità? Nel film, intanto, la sua musicalità fa da sfondo e da colonna sonora.